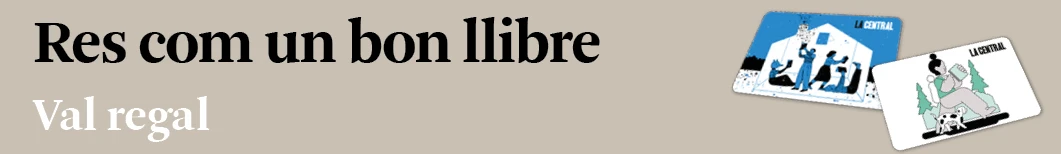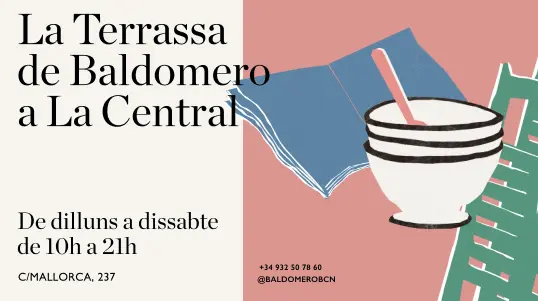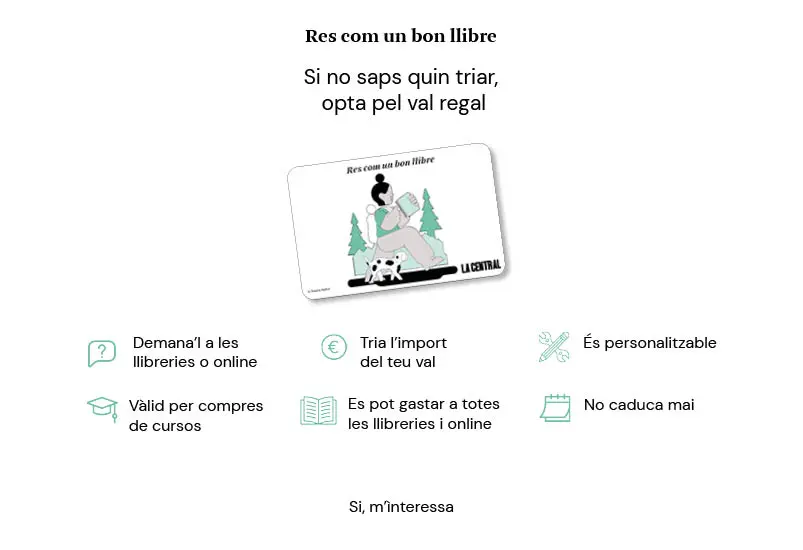Storia e dissoluzione. L´eredità di Hegel e Marx nella riflession


Storia e dissoluzione. L´eredità di Hegel e Marx nella riflession

Sense existències ara
Rep-lo a casa en una setmana per Missatger o Eco Enviament*Sobre el libro Storia e dissoluzione. L´eredità di Hegel e Marx nella riflession de Luciano Amodio publicado por Quodlibet al 2003:
Gli scritti di Luciano Amodio qui presentati ricoprono un arco temporale che va dagli ultimi anni ’50 alle soglie del 2000. Il volume, che realizza un progetto già concepito dall’autore poco prima della sua scomparsa, è suddiviso in due parti: la prima, Filosofia della storia e marxismo, comprende articoli e saggi dal 1957 al 1986; al centro vi è l’interesse per Marx, per le sue fonti e i suoi continuatori o seguaci, e l’analisi è ancora tutta interna all’orizzonte marxista dei decenni in questione. La seconda parte, Nuove riflessioni, va dal 1983 al 1998; in essa emergono nuovi interessi, pur nel mantenimento di una fondamentale coerenza, e non mancano sviluppi e ripensamenti anche radicali. Un posto di rilievo assume in questo periodo il pensiero di Eric Weil, il riaffiorante interesse per Kojève e quello, degli ultimi anni, per Heidegger. Segue un’Appendice che contiene l’importante Testimonianza di “Ragionamenti” (1980) e quella per il reprint della rivista “Discussioni” (2000). Un lungo percorso, in cui prende risalto il progressivo maturare di un pensiero critico coerente, sempre alla ricerca di un legame tra filosofia della storia e riflessione politico-culturale. E che nell’insieme pare sfociare in una sorta di disincanto antiutopista (mai però nichilista), che nella sua asprezza e coerenza aspira ad una razionalità del reale più profonda, al di là delle ideologie totalizzanti del capitalismo e di quel capitalismo pianificato che era stato il socialismo sovietico. Così egli scrive in Storia e dissoluzione, uno dei suoi ultimi saggi: “Guardando indietro non può credo sfuggirci la grandezza di quest’ultimo secolo, forse solo paragonabile, per la concentrazione di risultati e di fatalità della sua storia, al V/IV secolo avanti Cristo, quando attaccò la grande avventura della ragione, l’uomo osò per la prima volta ‘pensare’ e ‘mostrare’ così, dall’alto del suo nulla, l’accidentalità e l’irrazionalità dell’essere; e imporre le vie della scienza e della tecnica […]. Per la seconda volta, come ai tempi di Plutarco, gli oracoli tacciono e la desacralizzazione del mondo è verità anche per le grandi masse, non più soltanto nell’illuminismo degli intellettuali e nella banalità della borghesia positivista”. Da ciò la necessità di fronteggiare oggi l’estremo dei paradossi: il trasformarsi della fine della storia, come realizzarsi del suo fine, nella sua dissoluzione.El llibre Storia e dissoluzione. L´eredità di Hegel e Marx nella riflession de Luciano Amodio pertany a la matèria
Veure altres ressenyes de Filosofia
Ressenya
Mark Fisher
Deseo Postcapitalista
El impacto que tuvo la obra de Mark Fisher en el pensamiento contemporáneo es ya de largo recorrido. Muchos de sus lectores quedamos impresionados tras el análisis de la famosa sentencia “es más fá...

Temàtica
Creure en aquest món
Tenim necessitat de creure en el món perquè ell mateix es plega com a incessant esdevenir, i perquè com a subjectes que operem i situem la seva consciència en ell, estem cridats a respondre des de ...

Ressenya
Sara Ahmed
Manual feminista para aguafiestas
La primera vez que Sara Ahmed presentó a la feminista aguafiestas fue a raíz de un cuento de los hermanos Grimm en el que una niña testaruda, al no hacer caso a su madre, cae enferma y muere. Sin e...

Ressenya
Giorgio Agamben
Lo que he visto, oído y aprendido...
Lo que he visto, oído y aprendido… son los retazos de una existencia que, advirtiendo la proximidad del fin, se apresura a transcribir su fragmentario e imperfecto legado siendo consciente...